

Duecento anni fa, nel 1819, a Recanati, a soli ventun anni Giacomo Leopardi scrisse gli straordinari quindici versi (uno in più di un sonetto) de L’infinito.
Nel mio testo i primi venti versi (già col titolo Oltre la siepe il mondo non c’era più) li avevo pubblicati nei miei I dolorosi discorsi, edizioni Sottotraccia 2003. Gli ultimi venti versi (che iniziano con “Seduto sul fondo delle acque nel passato remoto del mare”) li ho scritti oggi, in queste ore. Alla fine di essi, una citazione molto bella dallo Zibaldonee che sembra alludere all’ansia di Leopardi di percepire sensazioni che s’aprano sull’infinito, e porta la data del 3 ottobre del 1821: “Come un filare d’alberi dove la vista si perda, così per la stessa ragione è piacevole una fuga di camere, o di case, cioè una strada lunghissima e drittissima, e composta anche di case uguali, perché allora il piacere è prodotto dall’ampiezza della sensazione; laddove se le case sono di diversa forma, altezza ec. il piacere della varietà sminuzzando la sensazione, e trattenendola sui particolari, ne distrugge la vastità”.

POESÌ di Rino Mele
Oltre la siepe il mondo non c’era più
A volte s’addormentava sulla collina, ne tornava
con graffiate foglie sui capelli, le mani
chiare come la luna appena sparita, che riappariva.
La siepe era gonfia d’insetti, minute
bare, i conigli di carta, i rami che pungono quando
tutto si stringe tra gli artigli di un gatto, il topo
e il suo universo, gli infiniti
mondi e lo straordinario mutare. Sulle
guance gli scorrono grani di aceto, guarda
le stelle, e il gatto
intanto divora la sua piccola preda. Nella sua mano
di bambino una ferita, il finito
dolore tra le dita, le palpebre rosse, le albicocche
mature nel verde che le divora,
e nasconde. Leopardi faceva un teatro d’inchiostro
e bave di lumache, aspettava
intorno al pozzo il secchio che s’apriva e rubava
il chiarore. Imparò ad essere felice
e ne piangeva nascondendosi alla bianca notte
materna, che lo innamorava della luna.
Seduto sul fondo delle acque nel passato remoto del mare,
guarda davanti a sé,
gli sembra ci sia una siepe ma non c'è nulla da vedere, rincorre
spaventosi aggettivi (interminati,
sovrumani) e in quel grammaticale orrore, cerca l’enigma
del tempo,
la giovinezza consumata.
Come un acrobata, in un disegno, non può cadere né rialzarsi,
sa di essere un superstite
ma non vede i relitti di nessuna nave, solo continue onde
senza rena.
Come da un piccolo acquario, si diverte a trarre via da quello sprofondo
la verticale forza dell'acqua,
s’immagina ai piedi di un colle - più vicina la siepe - come se
il naufragio
non fosse ancora avvenuto.
Oltre ciò che è finito (che può toccare e strazia) è l'abisso,
le spoglie del nulla, la veste d’aria delle cicale.
In quell’acqua che sale,
pensa una città, un filare d’alberi, una fuga di camere e di case.
________________________________
Rino Mele (Premio Viareggio Poesia 2016, terna finale con “Un grano di morfina per Freud, ed. Manni) scrive, il venerdì e il martedì, su “Agenzia Radicale”. Dal 2009 dirige la Fondazione di Poesia e Storia. Il nome della rubrica è “Poesì”, come nel primo canto del “Purgatorio” Dante chiama la poesia.
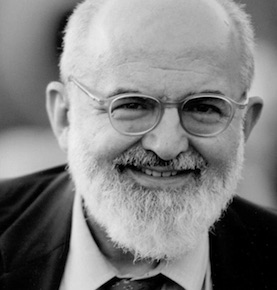
Leggi l'intera sequenza di POESÌ