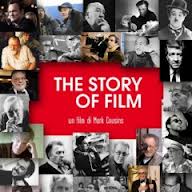


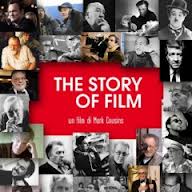
Concepito originariamente come documentario televisivo di poche ore di durata, The Story of the Film, an Odissey, del critico irlandese Mark Cousins (autore nel 2004 dell'omonimo libro), è lievitato con l'aggiunta di sempre nuovi materiali nelle mani del suo autore trasformandosi in un percorso lunghissimo, che avrebbe potuto diventare infinito.
Opera di Cousins, ma anche opera di tutti coloro che lo hanno aiutato nelle sue ricerche, sino al punto da rendere l'autorialità dell'impresa un merito collettivo. Si tratta di quindici episodi, suddivisi in ordine cronologico, per segmenti temporali della storia del cinema, della durata di un'ora ciascuno. 900 minuti.
Nella sua forma definitiva è stato presentato nelle sale per la prima volta ufficialmente al Toronto Film Festival. Si tratta, come ribadiremo in chiusura, di opera non priva di difetti e (inevitabili) lacune, ma di straordinaria importanza e istruttività. La scelta di una partitura cronologica è l'unica possibile, ma all'interno delle varie sezioni c'è anche una modellazione tematica, e un uso costante di rimandi interni, che favoriscono un andirivieni visivo ricco di suggestioni.
Il film ci conduce dai fratelli Lumière e dai primi trucchi alla Meliès, sino alla transizione da celluloide a digitale, segue il cinema di animazione e la spesso trascurata tradizione documentaristica, sino alle esperienze più recenti di quella sorta di secco neorealismo contemporaneo che trae linfa dai drammi di un mondo in crisi.
La 'settima arte' è osservata da ogni punto di vista. Se ne sottolinea la natura di industria inserita nei suoi diversi contesti storici e politici, senza dimenticarsi delle cinematografie indipendenti e underground da due dollari, si passano in rassegna le opere che consentono di periodizzare la storia del cinema, se ne seguono invenzioni ed evoluzioni delle tecniche, dal montaggio, ai primi piani, ai piani sequenza, all'uso dei dolly, le soggettive, le peculiarità delle inquadrature per autori, e così via.
Una voce fuori campo, corredata da una serie di interviste, ci aiuta a seguire le immagini che si susseguono, frammenti e spezzoni di film famosi e sconosciuti, editi e inediti (come una magnifica gag di Chaplin che gioca con un bastone ed un tombino, in una scena mai montata di Luci della città) prodotti in ogni parte del mondo. Appunto.
Un elemento connotativo di The Story of the Film è la sensibilità verso le cinematografie extraeuropee, ciò che dà all'opera in esame, e di riflesso al cinema come forma d'arte, un carattere globale e universale, mai rappresentato in passato con tanta completezza. Fra i materiali filmati offerti nei primi episodi, e cuciti come si diceva all'inizio secondo criteri tematicamente organici e uno sviluppo cronologico, vi sono fra i molti esempi fattibili, scene famose come l'uscita degli operai dalla fabbrica Lumière, la luna ammiccante di Meliès, brani di Griffith, e dei comici Keaton, Chaplin e Harold Lloyd (mentre sorprende la quasi totale assenza dei Marx), la carrozzina eizensteiniana poi ricitata da De Palma ne Gli intoccabili, ma anche più rare immagini dell'espressionismo tedesco o del pioniere maestro svedese Victor Sjostroem.
Il cinema nordico è valorizzato con Dreyer più che con Bergman, l'estetica formalista sovietica lasciata in relativa ombra, anche se al cinema di propaganda comunista e nazifascista è lasciato un ampio spazio, non privo di giudizi di merito anche positivi (dunque capaci di scindere politica e arte) sulla sua caratura tecnica, come nel caso dell'effettivamente splendido dolly che porta in alto la camera in Yo soy Cuba di Kalatozov (1964) per vedere dall'alto attraversando gli ultimi piani dei caseggiati una manifestazione popolare all'Avana o delle rappresentazioni gloriose e a modo suo non conformiste di Leni Riefenstahl.
Del cinema europeo del secondo dopoguerra sembra che tutto sommato Cousins apprezzi di più quello francese di quello italiano: un po' marginalizzati Fellini, Antonioni, Visconti, l'autore che Cousins ama di più è Bernardo Bertolucci, quello de La strategia del ragno o de Il conformista. Esaltati Godard (anche per il suo ruolo di teorico del cinema), Truffaut, Bresson.
Del grande cinema giapponese la vetta è attribuita a Ozu più che a Kurosawa. Opportunamente si è dedicato un episodio al new american cinema degli anni '70 del XX secolo e largo spazio è lasciato alle tradizioni più risalenti del cinema indiano e sudamericano, agli esiti più recenti delle tendenze delle realtà iraniane (Kiarostami) e del sudest asiatico (soprattutto coreano), nonché al cinema cinese (del quale il capofila è oggi senza dubbio Wong Kar-Wai).
Di quelli che un tempo si sarebbero chiamati terzo mondo o paesi in via di sviluppo, Cousins introduce alcuni maestri, più o meno noti ma assai poco visti: i celebrati e politicizzati autori della decolonizzazione (come Glauber Rocha per il Brasile e Ousmane Sembène per l'Africa); Youssef Chahine, forse il più importante regista egiziano ed arabo, il regista e produttore Mehboob Khan o soprattutto Satjayit Ray (l'autore della straordinaria trilogia di Apu) per l'India. Si potrebbe continuare con altre decine e decine di casi, il che esula da questo difficoltoso difficile tentativo di descrivere l'opera.
Dopo questa teoria di segnalazioni, poche osservazioni conclusive. Uno spettacolo che merita di essere visto prendendo appunti... Un'opera titanica, i cui limiti tutto sommato hanno l'alibi di essere funzionali all'obiettivo postosi dall'autore (che certo non è stato il voler fare una rassegna dei più bei film della storia del cinema) e appaiono comunque modesti rispetto ai meriti.
Ma vediamoli, questi limiti. I rimandi interni (intendo: confronti tra scene, tipi di inquadrature, soggetti) talvolta un po' forzati; le assenze di riferimenti a alcuni capolavori e registi di grande rilevanza (da un lato, si pensi a un Nashville, di Altman, dall'altro, a un Joseph Losey, al quale non è fatto nessun riferimento), il giudizio sostanzialmente positivo di film artefatti e demagogici come Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, 2004), forse la Palma d'Oro più ideologica e infelice della storia di Cannes; la messa a fuoco e a confronto, talvolta fuorviante, dei profili qualitativi dei registi, per cui un Bergman o un Buňuel ricevono pari o inferiore spazio di cineasti assai meno significativi e "storici"; e ancora, la tendenza eccessiva a esprimere giudizi tranchants su film o su scene che sarebbero stati i più belli della intera storia del cinema sotto l'uno o sotto l'altro aspetto (giudizi che solo in qualche raro caso rasentano il ridicolo, peraltro).
Tutto ciò detto, l'appassionato che non avesse avuto modo di seguire o di seguire per intero, con la necessaria continuità degli appuntamenti (e freschezza fisica!), The Story of the Film: an Odissey non si dovrà lasciar sfuggire la serie di dvd che sperabilmente entreranno in commercio nei prossimi mesi.
Giovanni A. Cecconi